Attenzione: contenuto potenzialmente sensibile, non adatto ai minori d’età.
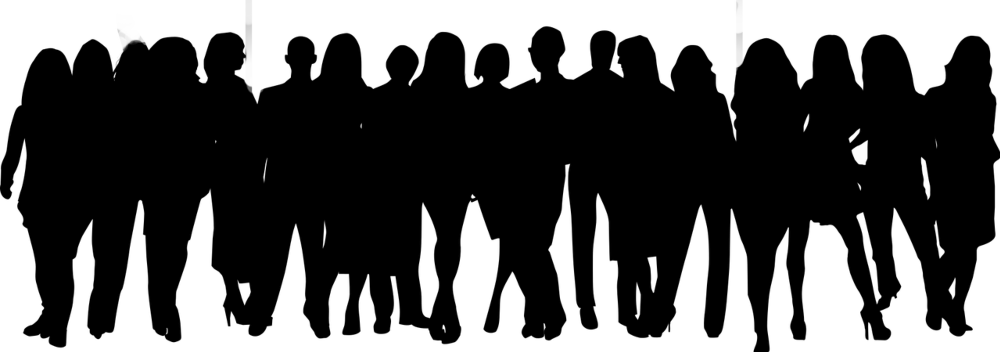
Testo tratto dal libro: Noi e il nostro corpo – scritto dalle donne per le donne, 1974
L’aborto in Italia
La battaglia sul problema dell’aborto si sta conducendo in Italia in un clima di tensione, che vede schierati da una parte i laici e dall’altra i cattolici. Ma mentre questa battaglia rappresenta per i progressisti il mezzo per superare l’arretratezza legislativa e sociale del nostro paese, il dibattito fra le donne è a un altro livello.
Una parte del movimento ritiene importante intervenire sul piano parlamentare per ottenere una legge che legalizzi l’aborto, considerato un diritto civile, un momento di maggiore potere e forza per tutte le donne.
Un’altra parte del movimento invece rifiuta di condurre la lotta indirizzandola secondo obiettivi di riforma sociale, che non possono che inserirsi in un sistema nemico delle donne: e soprattutto, inoltre, non vogliono che la sofferenza dell’aborto venga confermata come un “diritto”.
Perciò se le donne sono per l’abolizione dell’aborto, non possono essere contemporaneamente per la sua regolamentazione: tutto quello che si può chiedere è la depenalizzazione, cioè la cancellazione del reato. È un’illusione credere che il piano di regolamentazione delle nascite − necessità odierna del sistema patriarcale e capitalista − coincida con i bisogni delle donne.
Il problema dell’aborto non può essere considerato indipendentemente da tutta la questione relativa alla sessualità, ed è questa che va analizzata secondo i modi e i tempi che le donne stesse si danno nella loro lotta politica. Ricercando una sessualità propria le donne possono scoprire non soltanto perché rimangono incinte senza volerlo, ma soprattutto che cosa significano per loro maturità e riproduzione.
Cerchiamo ora di valutare il problema dell’aborto, al di là di qualsiasi valutazione morale o politica, in termini oggettivi di realtà.
Nel nostro paese dove l’aborto − regolato dal Codice Rocco del 1930 − è considerato un reato non contro le persone, ma contro la stirpe, è difficile poter fare una statistica attendibile. Le cifre presunte oscillano a seconda degli interessi delle parti in gioco, che tendono ad adattare il fenomeno a seconda delle proprie tesi, a sostegno delle medesime. Anche perché per esempio: donne morte per “cause imprecise” è un termine con cui di solito si cerca di camuffare la morte per aborto.
Il secondo problema da affrontare è “perché” le donne rimangono incinte senza desiderare la gravidanza. Oltre alle motivazioni di ordine psicologico, ci sono anche ragioni materiali ben precise. In Italia solo nel 1971 è stata abrogata con una sentenza della Corte costituzionale la norma che impediva la diffusione e il commercio dei metodi anticoncezionali. Di fatto, nonostante ciò la propaganda anticoncezionale è rimasta in Italia un fatto privato. Negli ambulatori pubblici (ospedali) e nelle mutue non viene offerta nessuna informazione e nessuna assistenza per la pratica contraccettiva. Questo limita un’adeguata scelta dell’anticoncezionale, aumenta il numero di gravidanze indesiderate, considerato anche la poca sicurezza e la nocività dei contraccettivi.
La concezione patriarcale della famiglia e della donna è un’ipoteca che grava sull’applicazione della legge sulla regolamentazione dell’aborto che si sta discutendo in parlamento (1977). Non è quindi da considerarsi una legge di liberalizzazione dell’aborto, ma una semplice depenalizzazione del reato, nei casi previsti.
Gli aborti a pagamento creano un giro di miliardi, a chi vanno questi soldi fatti letteralmente sulla pelle delle donne?
Uno dei nostri primi diritti, in quanto donne, è quello di scegliere se e quando avere figli. Solo questa libertà di scelta ci consente di realizzarci per noi stesse, per i figli che già abbiamo o che avremo in futuro, per il nostro compagno, per la comunità in cui viviamo. Lo strumento migliore per operare questa scelta è la contraccezione; ma la dolorosa verità è che a tutt’oggi, nel 1975, i metodi contraccettivi non sono sufficientemente efficaci da consentirci di evitare tutte le gravidanze non desiderate, mentre l’atteggiamento della nostra società verso la sessualità, l’educazione sessuale e l’assistenza sanitaria, rendono difficile alla donna, specialmente se molto giovane o povera, la scelta, l’acquisto e l’uso dei metodi contraccettivi più adatti.
La scelta dell’aborto non si compie mai senza conflitti.
Si preferirebbe sempre prevenire la gravidanza piuttosto che interromperla.
Noi del collettivo siamo convinte che la donna debba essere libera di scegliere l’aborto, e vogliamo l’aborto legale, a poco prezzo (gratuito sarebbe l’ideale, come tutte le forme di assistenza medica), volontario e sicuro, in un ambiente comprensivo, aperto a uno scambio soddisfacente di informazioni e di consigli.
A cura del Gruppo di lavoro: Per una medicina delle donne.
L’aborto negli Stati Uniti
Oggi negli Stati Uniti l’aborto è legale. Nel 1973, dopo anni di ricerca e di pressioni a tutti i livelli − gruppi femministi, centri di pianificazione familiare, movimenti per i diritti civili − la Corte suprema statunitense ha legalizzato l’aborto eseguito dal medico entro le prime 24 settimane di gravidanza (con qualche limitazione, diversa da Stato a Stato, dopo le 12 settimane).
In molte parti del paese l’aborto è tuttora meno facile, meno economico e più traumatizzante del necessario; e inoltre, la decisione della Corte suprema è oggi sottoposta agli attacchi di un esiguo ma potente movimento antiabortista. Abbiamo fatto molta strada, dai tempi dell’incubo degli aborti illegali, ma ne dobbiamo fare ancora tanta.
Un po’ di storia…
Tra gli argomenti degli antiabortisti, uno vuole che l’aborto violi una legge naturale antichissima. Al contrario per secoli e secoli l’aborto ai primi stadi della gravidanza fu legalmente tollerato, e in molte società, sia in Europa che più tardi in America, fu adottato come uno dei soli metodi sicuri di controllo delle nascite. Persino la chiesa cattolica ammise, con opportuna elasticità, il principio secondo il quale il feto viene vivificato dall’anima razionale, così che l’aborto fu considerato un delitto solamente dopo 40 giorni dal concepimento per il maschio, e dopo 80 giorni per la femmina (come si facesse a determinare il sesso del nascituro non era specificato). La legge inglese, che risale al XIII e che fu poi estesa agli Stati Uniti, dimostra una notevole tolleranza dell’aborto finché il feto non era considerato vitale, cioè fino alla comparsa dei primi movimenti, generalmente avvertiti dalla madre al quinto mese.
La maggior parte delle leggi che fanno dell’aborto un crimine non furono introdotte prima dell’Ottocento. Nel 1869 papa Pio IX dichiarò che l’aborto è sempre un omicidio, e in America entro il 1870 la nuova legislazione mise fuori legge qualsiasi forma di aborto salvo quello “necessario a salvare la vita della madre”.
Le ragioni per cui l’aborto diventò improvvisamente un “delitto” sono varie.
La prima è del tutto rispettabile: l’aborto era allora una operazione pericolosa, i metodi primitivi, gli antisettici scarsi, il tasso di mortalità elevato; e quindi la legislazione sull’aborto fu in parte dovuta all’ondata umanitaria della metà del XIX secolo e alla sua intenzione di proteggere la donna.
In secondo luogo, proprio in quegli anni l’assistenza ginecologica passava dalle mani delle levatrici, che sicuramente offrivano tra le loro prestazioni anche l’aborto, a quelle dei medici maschi che non sempre riconoscevano alla donna il diritto di interrompere la gravidanza.
In terzo luogo, le nuove cognizioni di biologia del concepimento e della gravidanza rivelarono che il feto è vivo anche prima che se ne percepiscano i movimenti, costringendo a riconsiderare la soluzione dell’aborto “prima che il feto sia vivo”.
In quarto luogo, contemporaneamente al diffondersi tra le donne delle cognizioni sul fenomeno del concepimento, alcuni governi e alcune confessioni religiose propugnarono la necessità della crescita della popolazione per tener testa alla espansione dell’industria e della colonizzazione di nuovi territori, e le leggi contro l’aborto collocarono la donna sullo stesso piano delle altre macchine dell’economia in sviluppo.
Infine, ed è forse l’argomento più insidioso, un movimento fortemente moralistico ossessionato dal dovere di bandire il sesso come “divertimento”, diede vita a una campagna contro l’aborto e contro il controllo delle nascite. Il sesso era riservato al matrimonio e il matrimonio alla procreazione: fuori dal matrimonio il sesso era immorale, e anche dentro il matrimonio, se troppo piacevole, non era esente da immoralità e veniva punito dalle gravidanze non desiderate.
Queste leggi ottocentesche, se non riuscirono a reprimere la vigorosa sessualità naturale della donna, riuscirono però, dato che la donna come la storia insegna legalmente o no ha sempre abortito, a costringerla sempre più sovente a procurarsi l’aborto per vie illegali. Nella nostra storia collettiva di donne, il trauma dell’aborto illegale è una componente che ci riempie di orrore e di rabbia. Tra le donne che per disperazione dovevano procurarsi da sé l’aborto o sottoporsi di nascosto a operazioni pericolose, il tasso di complicazioni, di sterilità e di morte era altissimo; si arricchivano, invece, le “mammane” clandestine che facevano pagare prezzi elevati per interventi non medici compiuti in assenza di condizioni igieniche, e vergognosa era la discriminazione contro le donne povere che dovevano correre il rischio dell’aborto clandestino mentre le loro simili più ricche si potevano pagare un medico comprensivo.
LA FABBRICANTE D’ANGELI
Intorno al 1965, negli Stati Uniti, un gruppo di donne e di uomini, spinti dall’esasperazione e dalla retta coscienza, cominciarono ad organizzarsi per tentare di riformare la legislazione sull’aborto. Ci trovammo contro coloro che vedevano nell’aborto la soppressione della vita o la minaccia a sacri principi come il “sesso per il matrimonio” e “il matrimonio per i figli”, i medici che non volevano rinunciare ai loro privilegi, i profittatori che gestivano il lucroso racket dell’aborto clandestino.
Il primo successo fu la liberalizzazione delle leggi sull’aborto in alcuni Stati (tra cui il Colorado e la California) che consentì alle donne, in certi casi specifici, di far domanda di aborto, lasciando la decisione ai medici e agli ospedali. La burocrazia medica e gli alti costi si allearono alla sostanziale opposizione della società all’aborto nel consentire soltanto a pochissime, per lo più benestanti, di beneficiare della riforma.
Nel 1969, quando alcuni stati avevano liberalizzato in qualche misura la legislazione, il 75% delle donne morte per aborto (per lo più clandestino) erano di colore, mentre il 90% degli aborti legali era stato praticato a pazienti private. La discriminazione atroce continuava.
Nel 1970, infine, lo stato di New York passò non una semplice riforma ma una quasi “abrogazione” della legislazione sull’aborto, che lo consentiva a tutte le donne incinte da meno di 24 settimane purché fosse compiuto da un medico in un ambiente sanitario. Entro il 1972 passarono, negli Stati dell’Alaska, delle Hawai e di Washington, statuti che si avvicinavano alla concessione dell’aborto su richiesta della donna, mentre in molti altri Stati i gruppi collegati al movimento femminista e ai movimenti per i diritti civili e per la pianificazione della famiglia si erano impegnati in vertenze giudiziarie che sfidavano le leggi restrittive.
Per due anni le donne che potevano permetterselo affollarono i pochi stati dove l’aborto era legale.
L’esperienza di New York ci insegnò che alcuni elementi della comunità medica erano disponibili a venire incontro all’esigenza dell’aborto. La sicurezza e l’efficienza dell’assistenza migliorò di anno in anno.
Dopo aver preso atto che l’aborto si era dimostrato sicuro e che esisteva un forte richiesta di assistenza legalizzata a New York, i testimoni di numerosissime azioni giudiziarie davanti alla Corte suprema degli Stati Uniti chiesero l’abrogazione di tutta la legislazione federale limitante l’accesso all’aborto.
La decisione della Corte suprema venne nel gennaio del 1973.
In particolare la Corte dichiarava che durante i primi tre mesi di gravidanza la scelta dell’aborto può essere compiuta soltanto dalla donna e dal suo medico. Verso la fine dei tre mesi, la competenza dello stato nella regolamentazione dell’aborto si riduce alla formulazione di regole che sanciscono dove si può praticare l’aborto e chi può farlo. “Soltanto quando il feto ha raggiunto l’età sufficiente a sopravvivere alla nascita (da 24 a 28 settimane di gravidanza) lo stato può proibire l’aborto [..] a meno che sia necessario a salvare la vita o la salute della madre”.
A questo punto è chiaro che la decisione della Corte suprema è stata solo un primo passo verso l’acquisizione del diritto all’aborto assistito per ogni donna. Certo la situazione è decisamente migliorata. Per le donne al di sotto delle 12 settimane di gravidanza sono stati aperti vari ambulatori alcuni dei quali non a scopo di lucro, come i centri di pianificazione della famiglia, mentre troppi altri sono finalizzati al profitto e quasi nessuno è finalizzato alla donna.
Gli aborti a pagamento creano un giro di miliardi, a chi vanno questi soldi fatti letteralmente sulla pelle delle donne?
Secondo i dati statistici, durante i primi quattro anni di applicazione della nuova legge della città di New York sono caduti: il tasso di mortalità infantile, di morte da aborto, di ricoveri in ospedali per aborti incompleti (clandestini), di mortalità e di complicazioni dell’aborto legale che è costantemente sceso.
Il movimento antiabortista: contro l’aborto si è levata una minoranza rumorosa, potente, ben finanziata. Non accontentandosi del fatto che la decisione della Corte suprema non costringe nessuno né a subire né a praticare l’aborto, questi gruppi vogliono assicurarsi che nessuno sia in grado di scegliere.
Come viviamo una gravidanza non desiderata
Nel momento in cui ci viene confermata una gravidanza non desiderata, tutte o quasi viviamo emozioni contrastanti e violente. Abbiamo paura che la nostra famiglia lo venga a sapere e ci punisca; paura di non saper fare i passi necessari; paura della prospettiva di una maternità. Forse temiamo l’aborto, anche nei casi in cui è legale e sicuro: farà male? Costerà di più di quanto io possa pagare? Sarò punita da qualche complicazione terribile e forse dalla sterilità? Mi sentirò in colpa? Rimpiangerò, in seguito, di non aver tenuto il bambino?
Ci sentiamo anche in collera, magari con noi stesse e il nostro partner perché non ci siamo preoccupati abbastanza del controllo delle nascite.
«Quando seppi che ero incinta, provai paura e rabbia perché non ero padrona del mio corpo. Mi infuriai perché lo IUD [la spirale] non aveva funzionato e mi sentii estranea, ostile ai miei organi sessuali. Mi parve di essere punita per la mia femminilità».
Oppure ci fa rabbia e tristezza il fatto di non avere i mezzi, l’aiuto o le condizioni di vita necessari a tenerci il bambino. Ci fa rabbia che tutte le conseguenze dei rapporti sessuali ricadano su di noi.
Qualsiasi decisione prendiamo, proveremo emozioni contrastanti, l’ambivalenza nei confronti della gravidanza è naturale. Se decidiamo di avere il bambino attraverseremo ugualmente momenti di risentimento, paura, incertezza. D’altro lato se scegliamo l’aborto non ne saremo convinte fino in fondo. Anche quando non vogliamo assolutamente il bambino possiamo provare un senso di orgoglio per i meccanismi del nostro corpo, che ci sembrerà strano se non sapremo quanto è naturale, e che ci indurrà a rimettere in discussione la scelta dell’aborto.
Se abbiamo già dei figli, ci parrà crudele dire di no a questa possibilità. Ci sembrerà di essere egoiste, soprattutto pensando all’importanza attribuita alla maternità dalla società in cui viviamo o al desiderio di una famiglia più grande, espresso dal marito o dai figli. Ci sentiremo in colpa, soprattutto se la religione che professiamo è contraria all’aborto o se a noi ripugna per ragioni morali porre fine a una vita. E a renderci ambivalenti sono anche le speranze: forse romanticamente crediamo che avere un bambino “sistemerà tutto” nel nostro rapporto.
Con tante emozioni confuse e poco tempo a disposizione, decidere sembrerà forse un compito impossibile, ma una volta presa la decisione, l’ambivalenza e i sentimenti contraddittori tendono a sparire. Comunque è importante per noi in quanto donne prendere una decisione attiva, che sia nostra, e non scivolare passivamente nell’una o nell’altra scelta.
Per aiutarci a fare un passo le cui conseguenze ci porteremo dietro per tutta la vita, ecco cosa si può fare:
- È importante trovare qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, avere una possibilità di “pensare a voce alta” a quanto abbiamo dentro prima di attuare qualsiasi scelta nei confronti della gravidanza.
- È importante fare partecipare l’uomo che ci ha messo incinte, condividere con lui le preoccupazioni e il dispiacere di una gravidanza non desiderata, di dargli la possibilità di condividere i nostri sentimenti e di offrirci appoggio. Ci sono, s’intende, uomini che non vogliono affrontare il loro impegno e che ci lasciano oppure che adottano il distacco emotivo.
- È importante pensare alle possibili alternative. Se si hanno dei dubbi.
Un’alternativa reale è portare a termine la gravidanza e poi offrire il bambino in adozione. Può essere un’esperienza affettiva molto difficile e lasciare un senso di perdita che può durare anni, ma può essere anche la meno sconvolgente.
Oppure pensare di allevare il bambino da sole, a riguardo è bene parlare con altre madri per capire almeno in parte la natura di questa esperienza, le difficoltà, il tipo di appoggio di cui si avrà bisogno. - È importante informarsi sull’esperienza dell’aborto. A volte l’ignoranza dei fatti dell’operazione − i rischi, i procedimenti, i costi − ci impedisce di prendere una chiara posizione pro o contro. Informazioni che si possono trovare presso i consultori e le organizzazioni per l’aborto, anche parlare con una donna che abbia abortito di recente darà un’idea di quanto vi aspetta.
Tratto da: Noi e il nostro corpo, Feltrinelli 1974